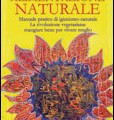articolo per Interdipendenza nov. – dic. 2007 – Daniela Muggia
Le 8 Strofe che addestrano la mente alla compassione, di Geshe Langri Thangpa, uno dei testi meditativi che hanno fatto del Dalai Lama quello che è, viste con gli occhi dell’accompagnamento della sofferenza.
In occasione della visita italiana del Dalai Lama mi è stato chiesto di scrivere qualcosa che esulasse, ma non troppo, dal tema della mia rubrica abituale, riguardante il modo di affrontare la morte, il lutto, la diagnosi infausta.
Con un personaggio come il Dalai Lama è quasi una passeggiata, perché ogni suo gesto, ogni sua parola ci rimanda alla compassione, il valore che maggiormente ispira l’accompagnamento della fine di una vita.
Così ho pensato che sarebbe stata una buona idea raccontarvi del testo che per 35 anni ha ispirato quotidianamente la sua compassione, facendola crescere a un livello tale da soverchiare il concetto stesso di nemico e amico.
Le Otto strofe per addestrare la mente – questo il titolo del breve testo di cui parlo – è opera del maestro tibetano Geshe Langri Thangpa, ed è contenuto in un libro dello stesso Dalai Lama, Le chiavi della meditazione quotidiana, del quale ho curato l’edizione italiana e la traduzione per i tipi di Amrita, in uscita a fine novembre. Come è uso del Dalai Lama, al testo in questione fa seguito un eccellente suo commentario.
Il maestro kadampa Geshe Langri Thangpa, precisa il Dalai Lama, considerava la pratica dello spirito dell’Illuminazione come la cosa più importante della sua vita, e queste sue otto strofe hanno lo scopo dichiarato di addestrare la nostra mente a sviluppare quel tipo di saggia, equanime, altruistica, incommensurabile compassione che contraddistingue i buddha e i bodhisattva, ossia coloro che hanno raggiunto o si stanno avvicinando alla completa Illuminazione, coltivandone, appunto, lo spirito.
Per i buddhisti tibetani non vi è dubbio che il Dalai Lama sia un esempio straordinario di tale realizzazione, e, a giudicare dal plauso che l’Occidente gli riserva (premio Nobel per la Pace, Medaglia d’oro del Congresso americano…) malgrado gli ostacoli politici, sembra che buona parte del mondo sia d’accordissimo.
Proprio come chi ama il pallone vorrebbe conoscere tutti i segreti dell’addestramento calcistico che fece di Pelé il Pelè che tutti ricordano, mi è venuto in mente che chiunque ami la pace e abbia una percezione della portata della compassione del Dalai Lama potrebbe volere, con altrettanta impazienza, conoscere i segreti del suo addestramento mentale, grazie al quale è diventato quello che è.
Se vi aspettate una ricetta complicata, siete in errore: per 35 anni ha meditato ogni giorno su otto, piccole strofe, alla portata di ciascuno di noi; e naturalmente, le ha messe in pratica.
Rassicuratevi, non intendo riassumere in questa sede il commentario del Dalai Lama per non rovinarvi il piacere di andarvelo a leggere, e ancor meno propinarvene una mia versione, perché ubi major minor cessat.
Mi limiterò a percorrere questi versi insieme a voi, leggendoli attraverso la mia specifica lente, quella della sofferenza da accompagnare quando essa diventa acuta, come spesso accade alla fine della vita; ma con la convinzione profonda che, se riusciremo a contemplarli ogni giorno, in contatto con la morte o con la sofferenza, ne usciremo trasformati, più vivi, più veri, e forse ci avvicineremo un poco di più al modello compassionevole che il Dalai Lama rappresenta per il mondo.
1. Con la determinazione di compiere il massimo bene di tutti gli esseri senzienti, persino migliori della gemma che esaudisce tutti i desideri, ch’io possa in ogni tempo averli a cuore.
Crescere non per noi stessi, ma crescere per aiutare gli altri. Non vi è maggior sprone alla crescita personale che lo scoprire che più maturiamo più si affina la qualità dell’aiuto che possiamo offrire al prossimo: è un aiuto che pian piano si spoglia delle nostre proiezioni personali, perché parte dall’ascolto dell’altro. Non lo sminuisce più, credendo di sapere cos’è bene per lui, ma ne onora la saggezza anche quando è nascosta, sapendo che quella saggezza è la vera natura di chi abbiamo davanti… All’inizio, e per molto tempo, si procede a tentoni, e si dicono parole sbagliate, o si fanno cose sbagliate. Ma la cosa straordinaria è che se nutriamo in noi questa motivazione pura, “ch’io possa crescere per aiutarti meglio”, la quale implica il riconoscere che abbiamo ancora tanta strada davanti, l’altro la percepisce, sente più quello che abbiamo nel cuore che quello che diciamo, ci sa autentici, presenti accanto a lui con tutta la nostra fragilità. Riconosce il nostro amore anche quando amiamo maldestramente. Avviene ogni volta, nell’accompagnare un morente. È come se l’avvicinarsi della morte gli fornisse una marcia in più: dopo aver passato la vita, come la maggior parte di noi, a sentirsi non amato, scopre che esiste un altro amore maldestro, quello dell’accompagnatore; ma scopre anche che, per quanto maldestro sia, è amore. È come se spostasse l’attenzione dall’avverbio al sostantivo, e in retrospettiva può accadere che si renda conto d’essere stato amato, e tanto, dalle persone importanti della sua vita, sebbene non proprio nel modo in cui avrebbe voluto. In questa scoperta c’è un immenso sollievo, ne converrete. Nell’accompagnamento c’è come una doppia dinamica: l’altro mi permette di esercitare ed affinare il mio amore, e per questo è prezioso per me quanto la mitica gemma che realizza tutti i desideri. E il mio amore maldestro diventa prezioso per lui, perché gli dischiude una visione diversa dei rapporti conflittuali della sua vita, lontana dalle recriminazioni, dal vittimismo, dall’odio. Insomma, gli dischiude una via di quiete.
2. Ogni volta che sto con gli altri, ch’io mi veda come il più umile fra tutti, e dal profondo del cuore, ch’io consideri gli altri supremi.
Nell’accompagnamento di un malato non c’è posto per la condiscendenza e per il compatimento. Anzi, la compassione è l’opposto del compatimento: è il desiderare che l’altro possa conseguire nel momento della morte quella pace profonda che non gli è riuscito di conseguire in vita, è fare di tutto perché ci riesca davvero, ma senza l’arroganza di crederci sapienti rispetto alle vie – aspre o lisce, consone o no al nostro modo di vedere le cose – che la sua saggezza sceglierà di percorrere, e decidendo di tenergli la mano comunque. Con questa motivazione interiore, come ho detto, ci si accorge ben presto che si riceve più di quanto si dà. Può accadere di essere sopraffatti dalla gratitudine, per questo. Frank Ostasesky dice che bussare alla porta di un morente è come bussare alla porta del Maestro, e ha ragione. Qualcuno s’immagina, qui, che io stia parlando della morte di un grande saggio o di una santa donna, ma non è così: sto parlando della morte della vecchina bizzosa, del manager depresso, della casalinga aggressiva e soprattutto della morte dei bambini. In ogni incontro vi è l’occasione per entrambi di trascendere la mera apparenza del ruolo, della personalità, e di trasformare il dolore. Per esempio, non puoi stare accanto a un morente nascondendoti dietro una maschera, perché la farà cadere. Sei costretto ad essere te stesso: la morte non ha tempo per i fronzoli, rende tutto più urgente, e, paradossalmente, più vivo.
3. In ogni mia azione ch’io esamini la mente, e appena sorgono le illusioni che mettono in pericolo me e gli altri, ch’io le affronti con fermezza e le allontani.
Nell’accompagnare chi è alla fine di una vita è più facile cadere nella tentazione delle proiezioni, del pensiero condizionato dalle esperienze precedenti, o dall’idea che io so e l’altro non sa, che io sono forte l’altro debole, che io sono intero e lui spezzato… Noi percepiamo, d’altronde, la realtà in modo distorto, come da dietro le spesse lenti colorate e deformanti dei nostri condizionamenti: un grande maestro dzogchen ha detto «il samsara è la mente volta all’esterno smarrita nelle sue proiezioni; il nirvana è la mente volta all’interno, a contemplare la sua vera natura». Le “illusioni” di cui parla il buddhismo sono essenzialmente questo: distorsioni percettive, condizionamenti di vario genere, insomma l’ignoranza di come le cose stanno davvero. Ed è da questo percepire distorto che ha inizio, ogni sofferenza, la quale paradossalmente produrrà ulteriori distorsioni percettive, e ulteriore sofferenza in un ciclo infinito, il samsara, appunto, dal quale si esce soltanto recidendo tali illusioni alla radice. Da esse nasce un rapporto non autentico con il reale, e dalle proiezioni nasce, nell’accompagnamento di un morente come nella vita, una relazione viziata dall’incomprensione. La proiezione è il contrario dell’ascolto empatico e profondo, lucido e aperto, su cui si regge ogni vero accompagnamento spirituale.
4. Quando vedo esseri dal carattere spiacevole, oppressi da violenti misfatti e afflizioni, che essi siano cari al mio cuore come se avessi trovato un tesoro prezioso e raro.
Beh, i morenti – come i viventi – non sono per niente facili. Non sempre, almeno. Sono, almeno all’inizio di un accompagnamento, un groviglio di sofferenze, faccende in sospeso, rapporti irrisolti, paure, attaccamento, disperazione… Ma se, per un attimo, memori della nostra aggressività (che è solo dietro l’angolo), cogliamo la loro aggressività come dolore soltanto, come sofferenza che ha da scoppiare in qualche modo, come una serie di distorsioni percettive con cui anche loro, come noi, devono fare i conti, veniamo investiti da una compassione coraggiosa, che ci permette di restare, di continuare ad amare invece di girare i tacchi.
5. Quando gli altri, per invidia, mi trattano male con la calunnia, l’inganno e così via, ch’io mi assuma la sconfitta e offra loro la vittoria.
L’invidia per chi è vivo, per chi domani stringerà ancora al petto il suo bambino, vedrà un altro tramonto sul mare, un’altra alba sulla collina… Quante volte ho incontrato quest’altra sofferenza, in chi è vicino alla morte! E, nell’accompagnamento del lutto, a volte l’ho sentita presente nei genitori che hanno perso i figli, quando scoprono che io sono madre, e una madre felice. È come se dicessero “tu non puoi capire”, come se si chiudessero in un’eburnea e turrita aristocrazia del dolore, quasi arrogante, che disconosce la vostra parte di sofferenza; creano essi stessi, spinti dal dolore soltanto, questa separazione dagli altri; allora vi sembra impossibile raggiungerli. È a questo punto che avete voglia di mollarli, di abbassare le braccia. O, peggio, vi si insinua dentro un serpentino pensiero ancor più separativo, del tipo “con tutto quello che sto facendo per te”. Dare all’altro la vittoria, qui, è non sentirsi offesi, è consentirgli di manifestare anche questa sua sofferenza senza per ciò abbandonarlo; è ricordarsi la motivazione per cui lo si accompagna, che da un lato prevede accoglienza totale e dall’altro il tentativo di farlo uscire dalla sua torre, non perché essa ci fa soffrire, ma perché l’altro resta bloccato nella sua sofferenza.
Se reagiamo, allontanandoci per esempio con aria sdegnata, ci sembrerà di aver vinto (“arrangiati, stai nella tua bagna”, si dice in Piemonte). Ma in realtà avremo perso, perché il condizionamento di cui l’altro è prigioniero avrà dettato anche il nostro comportamento, non solo il suo. Diversamente dall’agire, il reagire non è un atto di libertà, è il prodotto di un condizionamento, come una molla che, premuta dall’esterno, scatta.
6. Quando qualcuno che ho aiutato e a cui ho fatto del bene con grandi speranze, mi fa del male molto giustamente, ch’io possa considerarlo come il mio supremo maestro.
Più le leggo, e più mi pare che queste strofe siano fatte apposta per chi accompagna la sofferenza… Ma forse è solo perché ciascuno di noi, per il solo fatto d’essere al mondo, è continuamente chiamato ad accompagnarla… se non fa orecchie da mercante.
Mia nonna, per esempio, non fu facile da accompagnare per niente. Aveva una forma perniciosa di demenza senile, e non lanciava male parole, lanciava coltelli. Quelli veri, da cucina. Io ero una ragazzina, ma quello fu il mio primo addestramento in materia: non confondere la nonna con la sua malattia. La nonna, quando era in sé, mi voleva davvero bene. La sua malattia invece no. Fu, in questo, una suprema maestra: è grazie a lei che oggi, quando mi capita di incontrare persone aggressive (nella vita quotidiana, intendo) ne soffro molto meno di altri. Vedo infatti soprattutto la loro sofferenza, e il mio rapporto con loro resta aperto.
7. In breve, ch’io possa offrire direttamente e indirettamente ogni bene e felicità a tutte le mie madri, e in segreto assumermi le loro azioni dannose e la loro sofferenza.
“Tutte le mie madri”, nella terminologia del Dharma, vuol dire “tutti gli esseri senzienti”; si ritiene cioè che, nelle pregresse esistenze, tutti possano esser stati per noi madri o padri o fratelli o sorelle o figli, e che siccome anche una fiera è premurosa con i suoi cuccioli, tutti quanti devono essere stati altrettanto premurosi con noi. Si mette in evidenza la nostra dipendenza dagli altri non solo per sopravvivere (senza gli altri non esisteremmo), ma anche per crescere dentro (senza l’altro non c’è altruismo). È una strofa a vocazione eroica, perché allora questi innumerevoli altri contano più di me, che sono una soltanto; e mi ricorda un medico indiano che incontrai tanti anni fa. Fermarsi in un ashram, in India, prevede che si presti un servizio in
cambio dell’ospitalità, e a me era toccato in sorte di aiutare il medico, in quel piccolo dispensario col tetto di paglia. Mi disse di lavare le piaghe infette dei bambini. Io dissi “ok, dove sono i guanti?” e lui sorrise con quei sorrisi che sono come quando si accende una luce nel buio, e mimò il gesto di infilarsi dei guanti inesistenti. Mi disse “gloves of love”, “guanti d’amore”. Perché non c’era altro. Era il dispensario più sguarnito del mondo, e forse il più ricco…
8. Che tutto ciò non sia mai oscurato dalle macchie dei concetti delle otto preoccupazioni mondane. Ch’io possa, nel percepire tutti i fenomeni come illusori, privo di attaccamento, essere libero dalle catene del samsara.
Se ci si dedica ad accompagnare la sofferenza sospinti da aspettative (come quella d’essere considerati virtuosi) o da paure (per esempio quella di venire mal giudicati dalla società), non cresceremo e non accompagneremo.
Allo stesso modo, se crederemo l’altro davvero separato da noi, non cresceremo e non accompagneremo. Aspettative e paure sono il cemento che tiene insieme la grande distorsione percettiva, quella che ci fa credere d’esser dotati di un sé inerente e solido, magari anche permanente, sicché quando poi l’impermanenza si mostrerà con la malattia e la morte, verremo soverchiati dal terrore. Per forza! Ci saremo identificati (o avremo identificato l’altro) con ciò che muore, con ciò che non siamo: il corpo, la mente, il ruolo… dimentichi del fatto che la nostra vera natura è la vasta apertura di tutti i possibili, luminosa, cognitiva, dinamica, onnipervadente… e che è nella morte, che abbiamo la massima probabilità di trovarla.
Daniela Muggia
[Intervista a Daniela Muggia su Radio Radicale – La pratica del buddismo in Occidente
– clicca qui per ascoltare l’intervita ]