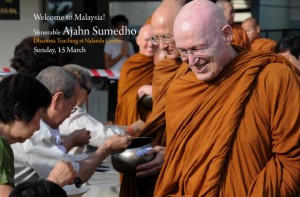 Mio padre è morto circa sei anni fa. Aveva novant’anni e fino a quel momento non aveva mai espresso sentimenti di amore e di affetto nei miei confronti. Fin dalla mia infanzia ho sempre pensato che non gli piacessi e mi sono portato avanti questa sensazione per la maggior parte della mia vita. Non avevo provato nessun tipo di amore o di affettuosa relazione con lui neppure io. Tra noi esisteva un superficiale rapporto formale: “Ciao, ragazzo, felice di vederti”. Sembrava si sentisse minacciato da me. Ricordo che ogni volta che tornavo a casa, dopo essere divenuto monaco buddhista, mio padre diceva: “Tieni presente che questa è casa mia e che tu devi fare come dico io”. Questo era il suo modo di salutarmi, e allora avevo quasi cinquant’anni. Non so proprio cosa mai immaginasse che potessi fare.
Mio padre è morto circa sei anni fa. Aveva novant’anni e fino a quel momento non aveva mai espresso sentimenti di amore e di affetto nei miei confronti. Fin dalla mia infanzia ho sempre pensato che non gli piacessi e mi sono portato avanti questa sensazione per la maggior parte della mia vita. Non avevo provato nessun tipo di amore o di affettuosa relazione con lui neppure io. Tra noi esisteva un superficiale rapporto formale: “Ciao, ragazzo, felice di vederti”. Sembrava si sentisse minacciato da me. Ricordo che ogni volta che tornavo a casa, dopo essere divenuto monaco buddhista, mio padre diceva: “Tieni presente che questa è casa mia e che tu devi fare come dico io”. Questo era il suo modo di salutarmi, e allora avevo quasi cinquant’anni. Non so proprio cosa mai immaginasse che potessi fare.
Mio padre voleva diventare un artista. Ma nel ‘29, quando arrivò la Depressione e il terribile crack, lui e mia madre persero tutto. Mio padre dovette accettare un lavoro di commesso in un negozio di scarpe per mantenerci. Quando cominciò la seconda guerra mondiale mio padre era troppo vecchio per essere richiamato alle armi. Voleva comunque dare un contributo alla guerra e divenne meccanico navale a Seattle. Non amava quel lavoro, ma era il modo migliore per dare un aiuto alla guerra. Dopo la guerra tornò a fare il rivenditore di scarpe e divenne il direttore di un negozio al dettaglio. Non che amasse questo lavoro, ma si sentiva troppo vecchio per cercarne un altro. Aveva sacrificato le sue aspirazioni per mantenere mia madre, mia sorella e me.
Quando entrai all’università negli anni ‘50 erano di moda gli studi psicologici. A quei tempi la tendenza era di prendersela con la madre per qualsiasi cosa non andasse per il verso giusto nella vita. L’obiettivo era focalizzato sulle madri: quello che avevano fatto causava a noi delle sofferenze. Non mi rendevo conto che quella sofferenza era un fatto naturale. Certo mia madre non era perfetta, ovviamente c’erano delle cose che avrebbe potuto fare meglio. Naturalmente però la sua dedizione, il suo impegno, il suo amore e la sua attenzione c’erano stati tutti, e tutti diretti principalmente, per quanto fosse nelle sue possibilità, a rendere migliore e più felice, la vita di mio padre, di mia sorella e la mia. Chiedeva ben poco per se stessa, e quando ho ripensato a questo, si è risvegliata in me la gratitudine (kataññū in pāli) verso i miei genitori.
Il Buddha ci esorta a pensare alle cose buone fatte per noi dai nostri insegnanti, dai nostri amici, dai nostri genitori, da chicchessia; e a farlo intenzionalmente, a coltivarlo, piuttosto che a lasciarlo accadere accidentalmente. I miei studenti che hanno una certa rabbia nei confronti dei loro genitori mi domandano come possono sviluppare gratitudine nei loro confronti. Insegnando la gentilezza amorevole, la pratica di mettā, su una base troppo sentimentale, si può di fatto aumentare la rabbia. Ricordo una donna in uno dei nostri ritiri che ogniqualvolta si arrivava al punto di rivolgere la pratica di mettā verso i propri genitori, cadeva in realtà in un sentimento di rabbia e poi aveva dei gravi sensi di colpa per questo motivo. Ogni volta che lei pensava a sua madre sentiva solamente rabbia. Questo succedeva perché lei usava solamente la testa, voleva praticare la mettā, sentiva una gamma completa di emozioni fuorché la gentilezza amorevole.
È importante porre attenzione al conflitto che esiste tra ragione e sentimento. Con la ragione pensiamo che potremmo dimenticare i nostri nemici e amare i nostri genitori, ma nel cuore sentiamo che non potremmo dimenticare mai quello che hanno fatto. Così quando sentiamo sia rabbia che risentimento, cerchiamo di razionalizzare: “I miei genitori sono stati cattivi, poco amorevoli, per nulla gentili, mi hanno fatto soffrire così tanto che non posso né dimenticare né perdonare”. Oppure: “C’è qualcosa di sbagliato in me. Sono una persona terribile perché non posso perdonare”. Quando succede questo, mi aiuta praticare la mettā verso i miei sentimenti. Se pensiamo che i nostri genitori siano stati poco gentili e amorevoli, noi possiamo rivolgere la mettā verso questo sentimento che proviamo nel cuore; senza formulare giudizi, vediamo cosa sentiamo e accettiamo questo sentimento con pazienza.
Se accolgo questo sentimento di avversione verso mio padre, piuttosto che negarlo, potrò da quel momento incominciare a superarlo. Quando lasciamo andare qualcosa con consapevolezza, possiamo liberarci del suo potere. La soluzione di un tale conflitto ci porta a contemplare che cosa è la vita. Una vita senza gratitudine è una vita senza gioia. Se la vita è una continua lamentela sulle ingiustizie e iniquità che abbiamo ricevuto e non ci ricordiamo delle cose buone che ci sono state fatte, cadiamo in depressione, cosa non certo poco comune ai nostri giorni. È impossibile immaginare che saremo mai felici di nuovo: pensiamo che ci sarà per sempre infelicità.
Quando divenni monaco buddhista in Thailandia, per fortuna incontrai un maestro, Luang Por Chah, conosciuto come Ajahn Chah, che è divenuto il centro catalizzatore della gratitudine nella mia vita. A quel tempo avevo trentatré, trentaquattro anni e la gratitudine non faceva ancora parte della mia esperienza di vita. Ero ancora molto coinvolto da me stesso, da quello che volevo, da quello che pensavo. Tuttavia, dopo qualche anno di noviziato da monaco buddhista, al sesto anno circa di vita monastica, ho avuto una esperienza di apertura del cuore kataññū katavedī, la gratitudine verso i propri genitori. Ero stato buddhista molti anni prima di conoscere Ajahn Chah. Ero fortemente interessato al buddhismo, sia dal punto di vista dello studio che della pratica. Ma faceva parte della mia voglia di fare, studiare, tentare di praticare. Quando divenni monaco questo mio atteggiamento era ancora vivo: “Voglio liberarmi dalla sofferenza. Voglio essere illuminato”. Non mi preoccupavo affatto delle altre persone, dei miei genitori, neppure di Ajahn Chah, con il quale abitavo in quel momento. Pensavo che fosse molto gentile, che fosse contento di me, ma non provavo gratitudine.
Pensavo che la vita mi dovesse tutto questo, era un modo di pensare veramente sgradevole. Quando si è cresciuti con tutti i comfort della classe media, come lo sono stato io, ci vuole molto per ammetterlo. I miei genitori avevano lavorato molto perché la mia vita potesse essere più confortevole, ma pensavo che avrebbero dovuto lavorare ancora più duro e che meritavo molto di più di quanto mi avessero dato. Anche se non era un pensiero consapevole, sotto sotto pensavo di aver meritato tutto quello che possedevo: le persone dovrebbero darmi queste cose; i miei genitori avrebbero dovuto darmi la migliore vita possibile, come avrei voluto che fosse. Ajahn Chah ebbe il compito di insegnarmi e guidarmi su questo punto.
In Thailandia praticavo con diligenza, cosa che ebbe un effetto determinante sulla mia vita monastica. Dopo aver partecipato a cinque ritiri nella stagione della pioggia (vassa) un monaco non è più considerato un novizio ed è libero di lasciare il monastero. Mi sembrava che essere guidati da un maestro fosse una cosa buona, ma volevo andare avanti da solo. Lasciai la Thailandia centrale per il nord-est. Dopo il vassa andai a fare un pellegrinaggio in India. Era il 1974 e decisi di andare come un tudong-bhikkhu, vagabondando di qua e di là, seguendo l’austera regola di pratica monacale. Qualcuno mi fece avere un biglietto da Bangkok a Calcutta e mi trovai a Calcutta con la mia ciotola per l’elemosina, il mio saio e seguendo la regola del monachesimo, senza un soldo. In Thailandia era stato facile, ma in India aggirarsi senza nient’altro che la ciotola per l’elemosina all’inizio mi spaventò. I cinque mesi che passai in India furono un’avventura, e ho ricordi piacevoli di quei momenti. La vita di un mendicante funziona in India. Tra tutti i paesi è proprio lì che si dovrebbe andare a mendicare, dove visse e insegnò il Buddha.
Cominciai a pensare ad Ajahn Chah e a riconoscere la gentilezza che mi aveva rivolto. Mi aveva accettato come discepolo, si era occupato di me dandomi degli insegnamenti e aiutandomi in ogni modo. E c’era il suo esempio. Se si dovesse desiderare di essere un buon monaco si dovrebbe essere come lui. Era un essere umano pieno di umanità, un uomo che mi ispirava, qualcuno da emulare e, devo aggiungere, non esistevano molti uomini per i quali provassi qualcosa di simile. In America i modelli da imitare non erano così interessanti per me: John Wayne o i presidenti Eisenhower o Richard Nixon, non erano certo dei modelli esemplari per me; star del cinema e atleti erano considerati molto importanti, ma nessuno di essi mi ispirava. Ma poi in Thailandia incontrai quel monaco. Era molto basso di statura; io lo sovrastavo di un bel po’. Quando eravamo insieme mi trovavo a sorprendermi del fatto che avesse tanto carisma. Aveva quel certo non so che che attraeva le persone. Così mi capitava di andare a cercarlo nella sua capanna verso sera o tutte le volte che era possibile. Coglievo tutte le occasioni per stargli vicino. Una volta gli chiesi cosa ci fosse in lui che attraeva tanta gente, e rispose: “Lo chiamo il mio magnetismo”. Usava il suo magnetismo per attirare le persone in modo da poter insegnare loro il Dhamma. Questo era il modo di usare il suo carisma, non al servizio del suo ego, ma per aiutare le persone.
Il Buddha, dopo l’illuminazione, al principio pensò che il Dhamma fosse così sottile da non poter essere capito da nessuno e che non ci fosse nessun modo per insegnarlo. Quindi, secondo la leggenda, uno degli dèi si fece avanti e gli disse: “Signore, per favore insegna il Dhamma a coloro che hanno poca polvere sui loro occhi”. Allora il Buddha contemplò con il potere della sua mente chi avrebbe potuto comprendere l’insegnamento del Dhamma. Ricordò i suoi primi maestri ma con i suoi poteri si rese conto che erano morti tutti e due, quindi ricordò i cinque amici asceti che avevano praticato con lui e che lo avevano lasciato. Spinto dalla compassione andò a cercarli ed espose il suo brillante insegnamento sulle quattro nobili verità.
Questo mi fa sentire kataññū katavedī del Buddha. È meraviglioso: sono qui – proprio io di questo secolo – e ho l’opportunità di ascoltare il Dhamma, di avere questo puro insegnamento ancora disponibile.
Il semplice fatto di avere un maestro vivente come Ajahn Chah non era come adorare un profeta che era vissuto 2500 anni fa, era come essere in contatto diretto con l’insegnamento stesso del Buddha. Forse proprio perché stavo visitando i luoghi santi del Buddha, la mia gratitudine cominciò a diventare molto forte. Poi pensando ad Ajahn Chah in Thailandia, ricordai che avevo pensato: “Ho fatto i miei cinque anni, ora sto per lasciare. Sto per avere una serie di avventure, potrò fare quello che voglio, sarò lontano dallo sguardo del vecchio monaco”. Mi resi conto allora che in realtà ero fuggito.
Quando sentii in me questo senso di gratitudine, ciò che volevo fare era solo tornare in Thailandia e offrire me stesso ad Ajahn Chah. Come potevo compensare un maestro come quello? Non avevo denaro, e in ogni modo non era certo interessato a questo. E allora pensai che l’unico modo con il quale avrei potuto renderlo felice sarebbe stato quello di essere un buon monaco buddhista e di tornare indietro per aiutarlo. Qualsiasi cosa volesse che io facessi l’avrei fatta. Con quell’intenzione, tornai dopo cinque mesi passati in India a consegnarmi al mio maestro. Era una offerta piena di gioia, senza alcun risentimento, perché era derivata da questa kataññū, vera gratitudine per le cose buone che avevo ricevuto.
Da allora mi resi conto che la mia pratica di meditazione cominciava a migliorare. Si incrinava in me quel forte egoismo; il mio tentativo di ottenere qualcosa, la mia aspirazione all’armonia, il mio desiderio di praticare e di avere una vita di pace priva di responsabilità. Quando realizzai tutto questo, le cose trovarono il loro posto. Ciò che mi era difficile come controllare la mente, divenne più facile, e constatai che la vita era diventata fonte di gioia per me.
L’ultima volta che andai a trovare mio padre, decisi che avrei tentato di stabilire un contatto di gentilezza amorosa tra di noi prima che morisse. La vita di mio padre negli ultimi anni era stata piuttosto infelice e lui era pieno di risentimento. Soffriva di un’artrite terribile e del morbo di Parkinson. Alla fine era stato ricoverato in un ospedale a lunga degenza. Era completamente paralizzato, poteva muovere solo gli occhi e parlare, ma per il resto il suo corpo era immobile. Era tremendamente risentito per questo: era stato un uomo forte e indipendente.
Quando lo andai a trovare mi resi conto che il suo corpo aveva bisogno di essere stimolato, così gli dissi: “Posso massaggiarti le gambe?”.
“No, non è necessario che tu faccia questo”.
“Ti verranno le piaghe da decubito, perché hai bisogno di essere massaggiato. Ho voglia di farlo
veramente”.
Rifiutò ancora, ma credo che ci stesse riflettendo.
“Penso che sarebbe una buona cosa”, gli dissi.
“Lo vuoi fare proprio?”.
“Sì”.
Cominciai a massaggiargli i piedi, le gambe, il collo, le spalle, le mani e la faccia; senza dubbio gli piaceva il contatto fisico. Era la prima volta che si lasciava toccare da me in quel modo. Il contatto fisico è pieno di significato, è un’espressione del sentimento. Cominciai a capire che mio padre mi amava realmente, ma non sapeva come manifestare il suo amore per me. Capii finalmente anch’io quell’amore e provai un’immensa gratitudine.
© Ass. Santacittarama, 2009. Tutti i diritti sono riservati.
SOLTANTO PER DISTRIBUZIONE GRATUITA.
Traduzione di Ida Tonini
Da “Tricycle”, primavera 2006, in italiano: “Sati”, 2006, n. 3.








